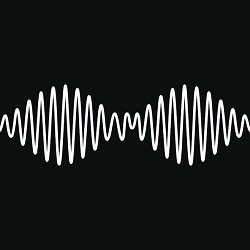Le scimmiette artiche crescono. Anzi, è da “Humbug” in poi che gli Arctic Monkeys non suonano più la stessa cosa che li ha resi famosi. L'influenza di Josh Homme (Kyuss, Queens of the Stone Age), che li ha deviati senza rimedio, sembra ancora tenerli per mano sebbene non sia più il loro produttore. Sono le idee melodiche di Alex Turner e il timbro so british tutto ciò che resta della band feticcio di una generazione, per il resto lo stile a cui approda “AM” è il risultato di un'attenta ibridazione con alcuni linguaggi rock più tradizionali. Ma questa volta, nonostante tutto sia cambiato, i risultati sono interessanti. Facciamocene una ragione se ci piacevano com'erano un tempo.
“AM” ha un pregio e un difetto. E' talmente ben scritto da essere in grado di fondere il feeling di Turner sia con le gagliardate alla Black Sabbath sia con le stilose ballate alla Lou Reed. Per contro il disco suona, così, meno contemporaneo di quanto non fossero quelli che avevano pubblicato a partire dal 2006. “AM” sembra più un'efficiente rielabolazione che una vera invenzione musicale. Tutto il disco, poi, scorre mantenendo la classe e il groove, nonché una certa moderazione che forse è più un regalo dell'età matura. Ciò diventa subito evidente, quando il singolo “Do I Wanna Know?” apre le danze, con un ritmo cadenzato e un riff di chitarra che ci accompagna con passo felpato all'hard indie di “R U Mine?”, fra echi della loro stessa storia e rimandi a quella di qualcun altro (“Dazed and Confused” vi dovrebbe ricordare di chi si parla). Il citazionismo diventa ancora più coinvolgente in “Arabella” che resuscita le detonazioni di “War Pigs” (dei Black Sabbath, per chi volesse ripassare la storia del rock) e le inserisce su un groove di basso che potrebbe essere stato di Michael Jackson; nel frattempo Turner canta con la nonchalance di un crooner, prima di lasciar spazio a un assolo conclusivo, che dai Monkeys non ti saresti mai aspettato. Poco dopo la scaletta riserva anche un lento di vecchia scuola, di quelli scritti per dare modo alle coppiette di formarsi in pista, parliamo di “No. 1 Party Anthem”, che, nella sua dimensione nostalgica, fa la sua porca figura. Aumenta ulteriormente il coefficiente di stile la pacata “Mad Sounds”, che segue a ruota: una canzone che potrebbe tranquillamente essere una rarità perduta dei Velvet Underground di “Loaded”. Nella seconda metà del disco le canzoni seguono quasi le stesse coordinate con qualche numero in meno e ispirandosi di più agli Ottanta (“Knee Socks”, “Why'd You Call Me Only When You're High?” le migliori della categoria).
Fine del disco. La band di Alex Turner con “AM” non si ripete, ma prosegue la propria evoluzione rivolta verso il passato: chiusa senza ripensamenti la fase giovane e frizzante da re del dancefloor, gli Arctic Monkeys si consolidano nel ruolo di “ponti” fra l'indie di ieri e il rock dell'altroieri.