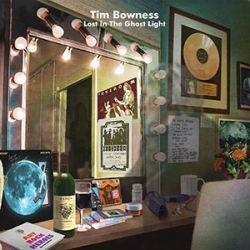Il contributo di un gran numero di nomi altisonanti legati al panorama prog non fa che sottolineare la devozione che questo disco mostra nei confronti di tale genere musicale, a partire dalle sue radici più classiche, fortemente ricorrenti nei quasi tre quarti d'ora di musica proposti. E se il sound evoca continui richiami a band come Genesis (soprattutto), King Crimson, Yes, Camel e via dicendo, il cantato risente spesso della natura art rock di Bowness, mostrando sfumature che spaziano da un tardo David Bowie allo stimato amico e collega Steven Wilson, qui all'opera nell'oramai consueto lavoro di missaggio e mastering.
L'atmosfera malinconica del concept si svela da subito attraverso le iniziali "Worlds Of Yesterday" (dal titolo emblematico) e "Moonshot Manchild", riflessi di un emozionale salto nel passato del protagonista. Se la prima traccia contiene infatti elementi maggiormente legati ad un approccio più moderno verso la musica progressive (facilmente riconducibili in alcune parti al capolavoro "The Raven That Refused To Sing (And Other Stories)" di Steven Wilson), la seconda apre con un piglio più classico (decisamente floydiano) e presenta sul finale una pregevole parentesi in stile Crimson.
L'insolitamente aggressivo inciso di "Kill The Pain That's Killing You" sembra poi dare uno scossone all'album, grazie alla presenza delle chitarre curate da Bruce Soord (Pineapple Thief) e della sezione ritmica composta dall'ex Porcupine Tree Colin Edwin e dalla batteria di Andrew Booker, ma si torna ben presto ad un clima cupo e tempi più lenti a partire da "Nowhere Good To Go". "You'll Be The Silence", magistralmente accompagnata dal piano ed intermezzata da un breve assolo di armonici di basso di Edwin, risulta il momento più profondo, nonché uno dei pezzi più riusciti del disco. Il finale di "You Wanted To Be Seen", tra un crescendo di archi, sintetizzatori e chitarre, rompe la quiete con un'incredibile carica di pathos, prima che "Distant Summers" chiuda egregiamente il tutto, presentando il contributo dell'inconfondibile flauto di Ian Anderson.
"Lost In The Ghost Light" è sicuramente un lavoro impegnativo, che necessita di ascolti attenti e avvezzi a quelle che sono state le colonne del prog rock. Se la tecnica e la cura in tutte le sue parti non sono questionabili, grazie anche all'impegno congiunto di così tanti virtuosi (non abbiamo ancora citato l'immenso lavoro di Stephen Bennett alle chitarre ed al tappeto di sintetizzatori, organi, mellotron e piano), l'aspetto lento e malinconico del concept tende talvolta a presentare momenti di stagnazione, in cui il lamento di Tim Bowness fatica a coinvolgere l'ascoltatore. Si parla chiaramente di un buon album, in cui l'artista britannico riesce egregiamente nell'emulazione dei mostri sacri del passato, anche se qualche pezzo un po' più diretto e coinvolgente (soprattutto nella parte centrale) non avrebbe certo guastato.