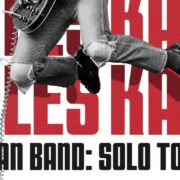“Dopo aver completato The Dark Side Of The Moon, mentre ascoltavo per la prima volta il prodotto finito, seduto nello studio di registrazione, pensai: ‘Questo è un album veramente eccellente’. È come se avesse toccato un nervo scoperto. Era come se chiunque stesse aspettando che qualcuno facesse un album come questo.”
È una giornata uggiosa e grigia. Piove e il vento sbatte le gocce di pioggia contro il vetro delle finestre. A guardare fuori sembra faccia molto freddo, quindi la decisione è molto semplice: meglio stare a casa ad ascoltare un po’ di musica. Ci avviciniamo al mobiletto dei dischi – l’angolo più sacro della casa – e non appena gli occhi cadono su “The Dark Side Of The Moon”, la decisione è presa. In 20 secondi netti il disco inizia la sua frenetica corsa in cerchio e il battito cardiaco di “Speak To Me” inonda la stanza. Chiudiamo gli occhi…
In questo momento ce lo immaginiamo bene Richard Wright seduto dentro gli Abbey Road Studios, incredulo davanti alla maestosità di quello che lui, David Gilmour, Roger Waters e Nick Mason hanno appena creato. Ce lo immaginiamo e forse riusciamo anche un po’ a comprendere quello che ha provato, quello che significano le sue parole profetiche. Sono passati 50 anni dalla pubblicazione dell’album più leggendario e iconico della storia del rock e di generazione in generazione, decenni dopo quella prima volta, il senso di incredulità e di impotenza che proviamo davanti a questa opera totale rimane nitido e inspiegabile.
Nel 1972 i Pink Floyd venivano dal discreto successo di opere come “Atom Heart Mother” e “Meddle”, ma sulla soglia dei 30 anni si erano resi conto di avere bisogno di esprimere concetti più reali e vivi, avvicinandosi a umanità, filosofia, empatia. Questo bisogno era così forte, che secondo le parole di Waters, “chiedeva di venir fuori”. Dopo aver composto i brani in una versione grezza e averli suonati in tour per diversi mesi, i quattro decidono di fare le cose a modo loro, esigendo solo il meglio. Viene reclutato Alan Parsons come tecnico del suono e ci si affida alle migliori e più innovative tecniche di registrazione dell’epoca – provate a pensare a un album con una qualità del suono migliore e fateci sapere se ne trovate qualcuno. Si lavora per sei mesi con meticolosità, controllando minuziosamente ogni aspetto dell’implacabile flusso creativo che colpisce i quattro musicisti. Il risultato è quello che tutti conosciamo e amiamo.
Lo amiamo e ci sentiamo compresi perché “The Dark Side Of The Moon” mette nero su bianco quello che tutti proviamo, ma che abbiamo paura di far uscire. Paura, empatia, morte, oscurità, tempo, follia. Concetti universali e senza tempo, che riescono a colpire nel 2023 esattamente come nel 1973 – e in ogni altro momento della storia dell’umanità. I Pink Floyd credevano così tanto nell’idea di coadiuvare musica e concetti, che tra le altre cose, decisero di disseminare l’album di registrazioni di frasi pronunciate dagli addetti ai lavori (roadie, produttori, impiegati dello studio) e ricavate attraverso particolari sessioni nelle quali le persone intervistate venivano fatte sedere in una stanza semibuia e dovevano rispondere ad una serie di domande scritte su un cartoncino. Questo perché, secondo le parole di Gilmour, “le persone non abituate ad essere intervistate dicono le cose più interessanti”. Le domande in questione, ovviamente, andavano a ricalcare i concetti che i quattro volevano esprimere nelle canzoni, partendo dalla semplicità (“Qual è il tuo colore preferito?”), fino ad esplorare le parti più nascoste e oscure dell’animo: “Credi di essere pazzo? Hai paura della morte? Quando è stata l’ultima volta che sei stato violento? Avevi ragione?”

La visione dell’interiorità umana secondo i Pink Floyd si mostra in due parti – non a caso i dieci brani sono divisi in cinque per lato. Nella prima ricalchiamo le varie fasi della vita, nella seconda i dettami che la regolano. Così, la nascita di “Speak To Me” con il suo battito regolare e una serie di suoni e voci inquietanti ci porta verso “Breathe”, esortazione a vivere pienamente la propria vita, pur con tutta la frenesia e la follia che ne consegue. Aspetti, questi, che vengono esplorati nei frenetici – appunto – synth di “On The Run”, mentre la mastodontica “Time” riflette su quanto questa vita ci avvicini alla vecchiaia – e alla morte – senza che ce ne rendiamo conto. All’atto finale dell’esistenza è dedicata “The Great Gig In The Sky”, il regalo più vero, oscuro e magnifico che Richard Wright e Clare Torry siano stati in grado di farci.
A partire dal rapporto con il denaro, che viene rivisto da “Money” in chiave quasi ironica e satirica, la seconda metà esplora l’opposizione tra empatia ed etnocentrismo (“Us And Them”), la consapevolezza dell’assenza di alternative (“Any Color You Like”) e la follia (“Brain Damage”). Un brano chiaramente ispirato a Syd Barret e sviluppato a partire dal bisogno di comunicare uno stato d’animo contradditorio, oscillante, nel quale luce e oscurità si sovrastano a vicenda. Ed è qui, nel climax dell’album dato dalla finale “Eclipse” che cogliamo il significato ultimo di “The Dark Side Of The Moon”: tutto quello che siamo, tutto quello che facciamo, tutto quello che ci definisce viene eclissato dall’oscurità interiore. Un concetto forse spaventoso, ma che ci unisce in quanto esseri umani.
“There is no dark side in the moon, really. Matter of fact it’s all dark.”
Mentre l’iconica frase di Gerry O’Driscoll (portiere degli Abbey Road Studios), accompagnata dallo battito cardiaco che inizia a dissolversi prima di fermarsi, ci risveglia da uno stato di trance, il sole fuori tramonta invisibile dietro una spessa coltre di nuvole. C’è una luce particolare. Ha smesso di piovere e il vento si è calmato. Dalla finestra ora il mondo sembra più invitante.