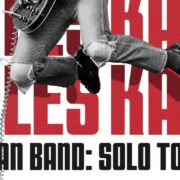Gli appassionati dell’estremo ubicati nel centro Italia non avrebbero potuto riprendere al meglio lo scapoccio live, grazie alla discesa, oltre il confine meridionale del Rubicone, dell’empio carrozzone del MORBIDFEST, evento quest’anno particolarmente significativo per una serie di motivi neanche troppo occulti. Poscia la pausa invernale dei concerti visto il perdurare dell’emergenza pandemica, assistere a uno show nel quale il numero e il censo dei gruppi coinvolti (Batushka, Belphegor ed Hate soprattutto) supera di gran lunga ogni rosea speranza, assume un valore simbolico importante. A ciò aggiungiamo che la maggior attrazione della serata, gli I Am Morbid, ritenuta dai maligni – e non solo – una semplice tribute band dei Morbid Angel, sarebbe stata impegnata a festeggiare, suonandolo per intero, il genetliaco di “Blessed Are The Sick” (1991). Una formazione che, accanto ai membri storici Dave Vincent e Pedro “Pete” Sandoval, tornati insieme per l’occasione – anche sorprendentemente considerate le ruggini passate -, include Kelly McLauchlin, chitarrista di Pessimist e Possessed, e Bill Hudson, fondatore dei power metaller NorthTale e ascia di Circle II Circle, Trans-Siberian Orchestra, U.D.O. e compagnia cantante. Una line-up eterogenea per estrazione che, sulla base dei resoconti delle tappe già affrontate dal tour, sembra funzionare molto meglio rispetto ai tempi dell’incarnazione natia, quella in cui militavano Tim Yeung e Ira Black. Inabissiamoci, dunque, nell’antro diabolico dell’Orion Live Club di Ciampino per rivivere insieme le emozioni della serata.
Serata? Non esattamente, dal momento che le porte si dischiudono addirittura alle 16:00, orario necessario per la tipologia della kermesse, eppure proibitivo per quanto concerne l’afflusso di un pubblico abbastanza esiguo, eccetto gli habitué duri e puri, che paiono far parte da secoli del corredo del locale romano. Niente file dunque, né pericolosi assembramenti, mentre all’esterno una temperatura fortemente umida e nuvoloni minacciosi preparano il campo al temporale scatenatosi in seguito, all’approssimarsi della mezzanotte. Ciononostante, complici le ante spalancate, le condizioni all’interno risultano piuttosto accettabili, con le birre – sciape – che iniziano a fluire copiose e i banconisti del merchandising ufficiale delle band maggiori presi a sistemare maglie, CD, vinili, libri e oggettistica varia.
Rompono il ghiaccio gli industrial avantgarde francesi Lecks Inc., un po’ la versione sbiadita e agée dei Turmion Kätilöt, che generano un tiepidissimo riscaldamento a causa sia di una prestazione non trascendentale, benché onesta, sia di una presenza sotto il palco parecchio sparuta, inadatta nell’invogliare a una performance convinta e coinvolgente. La situazione muta quando si entra in un territorio più consono allo spirito generale del programma, prima con la comparsa dei colombiani Eshtadur, fautori di un metallo della morte mastodontico, melodico e carico di groove, poi dei carioca Paradise In Flames, il cui symphonic blackened death, già non particolarmente originale, si affloscia in una prova a tratti distratta e abbastanza piatta. Un binomio sudamericano che provoca sensazioni contrastanti, spazzate via dall’ingresso dei Diabolical, combo svedese dedito a un death/black aggressivo e aperto a suggestioni ritualistiche. Laddove i dischi dei nordici si attestano sulla sufficienza spesso stiracchiata, on stage i quattro tirano fuori una prova trascinante, sommersi da coltri di fumo di consistenza padana e con un frontman, Sverker Widgren, che, per postura e physique du rôle, adombra un James Hetfield in salsa torbida. Se il primo mosh della giornata è merito degli scandinavi, il secondo è da ascrivere ai polacchi Hate, sinistri sin da una scenografia composta da teschi luminosi provvisti di corna e impilati su filiformi bastoni di legno. Malgrado il gelido atteggiamento dei musicisti e talune imprecisioni in sede ritmica, difetti coperti dal massiccio lavoro delle sei corde, il quartetto, pugni al cielo e volti grondante vernice biancorossa, suscita comunque l’entusiasmo di un ambiente finalmente gremito – sebbene non sold out -, con un set di scarsi quaranta minuti che pesca quasi totalmente da “Rugia” (2021). Tetragoni, ma d’effetto.
Una pausa e la torcia maligna transita tra le mani dei Belphegor: a differenza degli act precedenti che flirtavano con il Male e la morte, gli austriaci accendono sacrileghe vibrazioni blackened death, a partire da una mise en place blasfema al massimo grado, ricca di giganteschi crocifissi capovolti, candele spente in cima a supporti di metallo e crani caprini. I temibili salisburghesi, ormai attivi dal lontano 1993, emergono dalle quinte, titanici e imbrattati di face painting cadaverico, quando sta per terminare la “Sarabande” di Georg Friederich Händel, preludio a una “Swinefever – Regent Of Pigs” dalla consegna così selvaggia da scuotere le mura millenarie della Capitale e l’asfalto del vicino aeroporto. Il growl di un Helmuth Lehner tonico e inscalfibile, alternata agli scream del bassista Serpenth, guida una scaletta focalizzata sul compatto “Totenritual” (2017), un full-length di buon livello, terapeutico nel rilanciare, dopo qualche scivolone, le quotazioni di un gruppo pronto a rilasciare, nel mese di giugno, la nuova fatica “The Devils”. Pur riducendo al minimo le interazioni verbali, a parte i simpatici fuck al termine di ciascuna canzone, l’abitudine del singer di sputacchiare sulla torma, assumere pose bizzarre, coniare espressioni facciali da demonio lascivo e farfugliare un latino opinabile, manda in visibilio gli astanti, eccitati da una drammatizzazione cultuale consapevole della propria rozza teatralità. I dieci brani, interpretati con intensità ed esperienza, vengono accolti da sfrenati ruggiti di approvazione, confermando l’impressione di una recita inappuntabile, per dei vecchi satanassi che continuano a badare al sodo, evitando di impigliarsi in ricercatezze e sperimentalismi di sorta. Goat God Dominus!

Verso le ventitré giunge il momento clou degli I Am Morbid, anticipato, durante il soundcheck, dal training alle pelli di un Pete Sandoval che, a dispetto di una figura cagionevole, calamita, in virtù di una classe innata con le bacchette, l’attenzione di una folla intenta a rimpinzarsi di bevande alcoliche e tranci di pizza. Corporatura massiccia, collo taurino, carismatico come pochi e lingua da oratore imperiale, David Vincent accede per ultimo sul tavolato, da star consumata e autoreferenziale, trasformando il brusio della platea, cospicua senza arrivare al limite della capienza, in una vera ovazione da stadio. Supportato ai fianchi da due axeman di vaglia, il solido Kelly McLauchlin e il virtuoso Bill Hudson, che conferisce ai pezzi proposti una velata patina neoclassica – principalmente nel corso degli assoli -, il vocalist statunitense, con la sua ugola aggressiva e presaga, snocciola l’intero “Blessed Are The Sick” e una succosa manciata di tracce estrapolata dagli altri tre LP fondamentali dei Morbid Angel, “Altars Of Madness” (1989), “Covenant” (1993) e “Domination” (1995). La line-up funziona a meraviglia, restituendo appieno la potenza, la forza, l’incisività, le atmosfere sulfuree di eterne perle death , da “Immortal Rites” a “Fall From Grace”, da “Rapture” a “Eyes To See, Ears To Hear” passando per “Dominate”, “Where The Slime Live”, “God Of Emptiness” e “Dead Shall Rise”, cover grindcore estrapolata da “World Downfall” (1989), esordio dei Terrorizer degli stessi Vincent e Sandoval. Un’ora e un quarto ove nostalgia e furore si confondono, per un tuffo negli anni ’80 e ’90 capace di unire antichi affezionati e giovani leve in un unico e straordinario pogo intergenerazionale. Horns up!
Tocca ai Batushka di Bartłomiej “Bart” Krysiuk concludere la nottata attraverso la celebrazione di un’avvolgente liturgia nera munita di incenso, ceri e arazzi di foggia orientale; il nutrito ensemble di strumentisti, completamente avviluppati dai consueti e cupi sai ortodossi con cappuccio, cerca di creare, fra esalazioni di nebbia vermiglia, un clima di profonda meditazione, riuscendovi, però, solo parzialmente, correo l’assottigliamento della moltitudine, sazia della mattanza elargita dagli spettri semicarnali dei Morbid Angel. Per certi versi rilassanti a paragone delle sberle anteriori, i blackster di Białystok rimangono un’entità scissa, dando altresì dal vivo la percezione che manchi loro qualcosa. E quel qualcosa risponde al nome di Krzysztof “Derph” Drabikowski.
Il MORBIDFEST 2022 chiude i battenti, lasciando molte soddisfazioni, alcune fasi meno esaltanti e legittimi interrogativi circa l’assenza di rappresentanti nostrani, un aspetto da tenere a mente per una futura edizione della rassegna. Alla prossima, con la speranza che il festival diventi un appuntamento fisso da gustare e rigustare all’infinito.