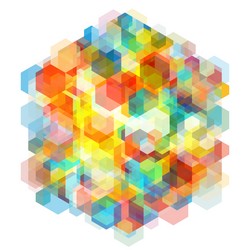Bisogna andarci cauti. Il terzo album è un traguardo, certo.
Un traguardo che può innalzare o inabissare.
Non capita più tanto spesso di imbattersi prontamente sul sentiero musicale di una band agli esordi. Una buona band, per intenderci. Quella stessa band, magari forte di un debutto che oltre a suonare fresco e nuovo, annulla quanto fatto dai maestri del genere in questione. Quando a suo tempo uscì "One", ciò che venne detto (e scritto) riguardo i TesseracT fu proprio che la band aveva tutte le potenzialità, musicali e stilistiche, per reinventarsi sempre e comunque. Teoria che proseguì come previsto con il successivo "Altered State", che oltre a stupire per le sue molteplici sfumature musicali, rese l'uscita del singer Dan Tompkins quasi intangibile, trovando anzi nella duttilità vocale del giovane Ashe O'Hara, nuova linfa per andar avanti.
Eccolo arrivare quindi, "Polaris", nuovo album della band inglese.
Lui che fin da subito si prefigge di cambiar tutte le carte in gioco.
Lui che accompagna i suoi musicisti, tra i corridoi della Kscope.
Timido, suscettibile, talvolta avvolto da pentagrammi apocalittici.
Introspettivo quanto basta per permettersi d'esser restio a farsi capire del tutto.
Anche e sicuramente coerente con il percorso intrapreso con il suo predecessore, maturato invece rispetto a ciò che rappresentava "One".
"Polaris" è enigma, se la si deve dire tutta. Abbandonato il candido biancore visivo del precedente album, questo nuovo capitolo si immerge in una tavolozza di colori che sembra tanto voler nascondere quell'atmosfera d'introspezione che solo il primo ascolto "regala". Le virgolette non sono un caso, sapete. "Polaris" non regala proprio nulla. Scorre lento e sicuro, lasciandoti credere che questo nuovo inciso targato TesseracT, sia l'innominabile buco nell'acqua che non vorresti mai ascoltare dopo due ottimi album. Fatecelo dire, cari lettori: ci vuole una continua dose di caparbietà per attestare che non ci si trova dinanzi ad un passo falso. Armatevi dei vostri migliori auricolari quindi, abbiate pazienza. Una volta intrapreso il viaggio più volte, è allora che ritrovi la maestria di Amos Williams al basso, quel cuore pulsante (trionfante nella bellissima "Hexes") rappresentato dalla batteria di Jay Postones per poi lasciar posto al duello chitarristico tra James Monteith e Acle Kahney in un tripudio di ritmiche e intriganti concatenazioni strumentali. Nonostante i buoni pronostici, quasi cercando di non far trasparire lo scetticismo, aspettiamo i primi accenni canori del ritrovato Dan Tompkins. E' anche qui ci ritroviamo a ribadire una coerenza di fondo che segue ancora una volta ciò lasciato da "Altered State": la voce di Tompkins affronta stavolta la sua delicatezza, certo non priva dell'energia che la contraddistingue, eppure si lascia stregare da quello spettro vocale innocentemente efebico e atmosferico che a suo tempo fece la fortuna del precedente vocalist. L'approdo in questo tipo di terre vocali però non regala sempre perle musicali, anzi alcune volte sembra quasi limpida la voglia di Tompkins di calcar la mano; a farne le spese sono brani come "Phoenix", sfigurata da stridulì (presenti in minima parte anche in "Utopia"), lontani persino dalla vasta gamma personale di Dani Filth.
Nessuno dei brani sembra aver quel piglio "facile" per presentarsi immediatamente all'ascoltatore ma, come già detto in precedenza, dopo vari ascolti le prime a svelarsi per capire un minimo di questo "Polaris" saranno "Seven Names", "Tourniquet" e la movimentata "Dystopia". Ma, in fin dei conti, sapete ciò che c'è di vero? Badate quanto basta alla nostra "classifica". Se c'è una cosa in cui questo "Polaris" riesce, è presentarsi in modi diversi, mutando e crescendo di volta in volta.